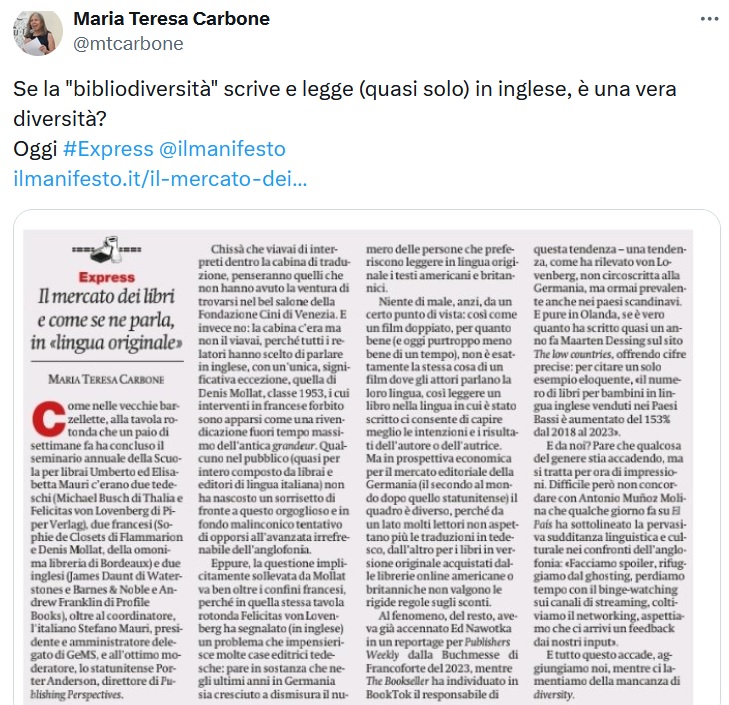(C) 2021 Antonio Zoppetti, riproduzione riservata
L’inglese internazionale non è solo quello commerciale o turistico che può essere anche comodo per farsi capire quando si va in vacanza in qualche Paese di cui non si conosce la lingua. Questo inglese è in fondo una riduzione a pochi vocaboli e a frasi di circostanza che hanno un pura funzione comunicativa. Ma una lingua non è solo comunicazione, si porta con sé processi molto più profondi che coinvolgono il modo di pensare. Il filosofo, logico e matematico viennese Ludwig Wittgenstein, nel suo Tractatus pubblicato un secolo fa, scriveva: “I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo”, perché il linguaggio descrive la realtà, e non è possibile pensare e descrivere la realtà in modo indipendente dal linguaggio. Come ha osservato Andrea Zhok: “Chi pensa a una lingua naturale come a un vestito neutrale, da indossare a piacimento senza che nulla cambi nella propria personalità e nel proprio pensiero, ha semplicemente un’esperienza della lingua povera, meccanica, circoscritta e meramente tecnica.”
Non si può allora dimenticare che l’inglese turistico e ristretto si basa sulla semplificazione della lingua madre dei popoli e delle culture dominanti, e questa lingua naturale ha una profondità che travalica la semplice comunicazione, è espressione del pensiero. Quando l’inglese internazionale diventa la lingua da esportare e da utilizzare in ambiti che coinvolgono il modo di pensare – come quando lo si impiega per la formazione universitaria, ma anche nella scienza o sul lavoro – entrano in gioco fattori complessi che hanno a che fare con i processi di astrazione e la concettualizzazione che sta sotto la lingua.
Fare dell’inglese la soluzione internazionale che ricostruisce la torre di Babele attraverso un grattacielo che assomiglia a quelli americani in cui si parla l’angloamericano non rappresenta solo un problema etico, per cui per essere “internazionali” si dovrebbe rinunciare alla propria lingua nativa per utilizzare quella di chi è più forte. Questa strategia ha anche degli “effetti collaterali” che portano a schiacciare le altre lingue e a non riconoscere il valore del plurilinguismo e delle altre culture. Ma soprattutto, l’inglese globale entra in conflitto con le altre lingue e si trasforma in una minaccia per quelle deboli o minoritarie.
L’anglicizzazione degli idiomi locali e le ibridazioni
L’effetto collaterale più evidente, e tutto sommato meno profondo, lo si vede nell’anglicizzazione di ogni idioma, nello “tsunami anglicus”, per dirla con Tullio De Mauro, che si riscontra in ogni luogo. Gli anglicismi sono i detriti del globalese, la lingua della globalizzazione, che penetrano in modo sempre più ampio e profondo nel lessico di ogni parlata, un fenomeno così pervasivo che ovunque ha ormai il suo nome: l’itanglese corrisponde a ciò che in Francia si chiama franglais, in Spagna spaglish, in Germania Denglisch, in Svezia swinglish, in Grecia greenglish, in Russia runglish e così via sino al konglish per il coreano o il japish per il giapponese.
Queste contaminazioni, quando diventano troppo estese e pesanti possono snaturare le lingue locali, e possono dare origine a lingue ibride, cioè mescolate, o creolizzate, il che si verifica quando il mescolamento non è paritario e la lingua dominate schiaccia quella di rango inferiore. Questo fenomeno avviene di solito nei territori dove esiste un bilinguismo locale che porta appunto alle enunciazioni mistilingue e al passaggio di un codice all’altro nelle stesse frasi. È il caso per esempio dello spanglish che ha preso piede nell’America latina, diffuso nelle comunità bilingui tra ispanici, portoricani o messicani, ma anche nelle aree statunitensi a forte presenza ispanica.
In altri casi il bilinguismo sul territorio porta invece a una diglossia, cioè a una gerarchia delle lingue dove la lingua locale diventa quella di serie B, quella del popolo, delle fasce deboli e “ignoranti”, mentre l’inglese è quella di serie A, della cultura, dei ceti sociali alti.
Questa diglossia è forte per esempio in India, dove l’inglese è stato introdotto ai tempi delle colonie britanniche. Da una parte è nata la variante dell’angloindiano che ha ormai assunto le sue forme e connotazioni particolari, tanto che Salman Rushdie ha rivendicato con orgoglio l’indian english dei suoi libri, che travalicherebbe quello ortodosso imponendosi come nuova varietà “autonoma”. Ma questa variante, più che essere sbandierata come il trionfo del meticciato e la lingua di quella popolazione, appare più come figlia del colonialismo. E proprio in India, l’inglese, ortodosso o meticcio, è diventato un simbolo, una lingua superiore, un modo di distinguersi socialmente con delle ricadute molto pratiche. Parlare l’hindi appartiene ai ceti bassi, mentre avere accesso all’inglese è un segno di cultura, un modo per elevarsi, al punto che per il 95% degli uomini la sua conoscenza è diventata un requisito fondamentale da cercare in una donna da sposare, come fosse una dote, perché una moglie che conosce l’inglese è essenziale per frequentare l’alta società (1), mentre dell’hindi ci si vergogna. Lo si vede persino in alcune pellicole di Bollywood, una delle più celebri è Quando parla il cuore (2) che narra le vicende di una donna alla ricerca dell’indipendenza, del rispetto e del riscatto proprio attraverso la conoscenza dell’inglese che va a imparare a New York.
Il globalese che minaccia le lingue minoritarie
Un altro ben più grave effetto collaterale del globalese consiste in un ulteriore passo rispetto al ricorso all’inglese per motivi sociolinguistici, che sono una scelta per elevarsi socialmente e per identificarsi nel gruppo di appartenenza elitario. Il proseguimento di questo processo può portare all’abbandono della propria lingua. Ed è in questo modo che le lingue minori possono scomparire e morire. Questo fenomeno può essere spontaneo, ma può anche essere il risultato di un’imposizione, proprio come è avvenuto, ma avviene ancora oggi, in Africa. È un processo raccontato molto bene dallo scrittore africano Ngũgĩ wa Thiong’o (3) che ne ha vissuto le conseguenze sulla propria pelle. Tutto ha avuto inizio nel 1884 a Berlino, quando venne sancita la spartizione dell’Africa non solo nelle nuove frontiere disegnate a tavolino, ma anche nelle diverse lingue delle potenze europee. I Paesi africani, che un tempo erano colonie e oggi assomigliano a neocolonie, sono stati divisi in territori di lingua inglese, francese e portoghese. Con la nascita delle scuole coloniali che impartivano le lezioni nelle lingue imposte, questo colonialismo linguistico fu portato a termine, determinando la morte di molte lingue locali minoritarie. A lungo andare gli africani hanno cominciato a identificare e definire la propria identità attraverso queste lingue (4), e ancora oggi sono francofoni o anglofoni, anche se successivamente sono sorte anche le aree arabe. Per questo motivo Thiong’o, davanti all’odierno strapotere del globalese, invita a ribellarsi all’inglese, la lingua colonizzatrice che “fiorisce sul cimitero degli altri idiomi.” (5) Ma anche il tunisino Claude Hagège ha denunciato “un olocausto che fluisce senza sosta, apparentemente nell’indifferenza generale” determinato soprattutto dall’inglese, che “svolge un ruolo di primo piano tra i fattori della morte delle lingue”. (6) Ha calcolato che nel mondo “ogni anno muoiono venticinque lingue: un fenomeno di dimensioni spaventose”. (7) Se oggi quelle vive sono circa 5.000, fra un secolo saranno la metà, se non cambia qualcosa.
Queste preoccupazioni non si trovano solo in autori legati all’Africa, e la costatazione per cui tantissime lingue minori scompaiono dal nostro pianeta, con una velocità maggiore di quella della scomparsa delle specie viventi, è al centro delle riflessioni della finlandese Tove Skutnabb-Kangas, che insegna all’università danese di Roskilde e all’accademia universitaria di Vasa in Finlandia, e che da anni si batte per i “diritti linguistici” delle popolazioni e delle minoranze, linguistiche e culturali. Il riduzionismo monolinguistico, secondo la studiosa, non è solo ingiusto, ma è un “cancro” a cui va contrapposto il riconoscimento dei diritti linguistici. (8)
L’inglese internazionale non minaccia solo i Paesi africani o lontani, a rischio ci sono anche le lingue d’Europa, quando sono parlate da un ristretto numero di persone, e il caso dell’Islanda è il più grave.
Il caso islandese e la “minoritarizzazione digitale”
Gli islandesi sono poco più di 300.000, un numero di parlanti estremamente basso, così basso che non sono considerati un mercato appetibile per le multinazionali che non hanno convenienza a tradurre in quella lingua. I film e le serie tv americane per tradizione non sono mai doppiate, ma al massimo sottotitolate, e nell’era di Netflix tendono a circolare direttamente in lingua inglese. L’islandese non è contemplato come lingua della tecnologia basata sul riconoscimento vocale, da Siri ad Alexa, e la conseguenza è che tutto avviene direttamente in inglese, e anche le localizzazioni di piattaforme come Facebook in islandese sono parziali e malfatte.
Il crollo economico di quel Paese, avvenuto nel 2008, ha portato all’abbassamento dei prezzi e all’aumento vertiginoso dei turisti: nel 2008 erano cresciuti sino a 500.000, ma nel 2017 sono stati 2 milioni (più di 5 volte il numero degli abitanti dell’Islanda) e l’inglese è diventata la lingua che di norma si usa anche nei locali e nei negozi, al punto che nei bar e nei ristoranti del centro di Reykjavík non di rado ci si rivolge ai clienti direttamente in inglese.
Quello che sta avvenendo è stato definito dal linguista Eiríkur Rögnvaldsson, professore dell’Università d’Islanda, il fenomeno della “minoritarizzazione digitale”, dove una lingua viva e parlata nel mondo reale si trasforma nel mondo digitale in una lingua secondaria che di fatto non esiste, o lascia poche tracce di sé. Questo fenomeno ha delle ricadute pesanti sui parlanti, perché ormai l’ambiente digitale e quello televisivo sono diventati preponderanti e il tempo che la gente dedica a queste attività è sempre maggiore. Se le interfacce dei cellulari e l’ambiente virtuale parlano l’inglese, finisce che diventa la lingua prioritaria e questo ha un impatto forte soprattutto sulle giovani generazioni, che trascorrono sempre più ore in un mondo digitale che li espone al solo inglese. Su telefonini, tablet, computer, televisioni è tutto un pullulare di giochi, film, serie televisive, video e canzoni in inglese. In questo modo ci si abitua a pensare in inglese e le parole native non vengono più in mente. E in inglese non solo si interagisce con le piattaforme sociali e tecnologiche, ma sempre più spesso anche con gli altri, vista la larga conoscenza di quella lingua. Al punto che gli insegnanti delle scuole secondarie riferiscono che i quindicenni, in cortile durante la ricreazione, sempre più spesso parlano tra loro in inglese. Da una stima sul fenomeno risulta che un terzo degli islandesi dai 13 ai 15 anni parli in inglese con i propri amici, (9) mentre alcune indagini rilevano che nelle fasce dei più piccoli, i bambini riferiscono agli specialisti che non sono in grado di indicare un termine islandese per molte delle figure che vengono loro mostrate. Il rischio paventato da Eiríkur è quello di assistere a una nuova generazione che si forma senza una vera e propria lingua madre. (10) Per i giovani che si nutrono di prodotti di intrattenimento digitali in inglese, in un Paese dove persino al suo interno la lingua locale è sempre meno diffusa, la domanda che ricorre è: “A cosa mi serve parlare in islandese?” E a quel punto passano direttamente all’inglese.
Davanti a questo fenomeno preoccupante il governo ha compreso il problema e varato politiche linguistiche e provvedimenti per favorire la lettura dei libri in islandese, visto che ha subito un calo notevole negli ultimi anni. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro da destinare alle iniziative che lavorino a tecnologie in lingua islandese, (11) che sono fondamentali per arginare l’invadenza dell’inglese globale. Se in Italia la scarsa conoscenza dell’inglese ci mette al riparo dall’abbandonare la nostra lingua, che ha anche una forza e una storia letteraria ben diversa da quella islandese, vediamo lo stesso i risultati che sul piano linguistico comportano le interfacce informatiche concepite nell’anglosfera con i termini dell’anglomondo. Il 50% dei lemmi marcati come informatici, sul Devoto Oli, sono appunto in inglese crudo, e se fino agli anni Settanta potevamo esprimere l’informatica nella nostra lingua, oggi non è più possibile, senza la stampella degli anglicismi. Anche se da noi non esiste alcun bilinguismo sul territorio, esiste però un bilinguismo virtuale e culturale rappresentato dalle interfacce con cui interagiamo in Rete che parlano in inglese e che a livello lessicale abbiamo rinunciato a tradurre passando alla strategia dell’importazione in modo crudo, che consiste nell’adottare invece di adattare.
Mentre in Francia e in Spagna le accademie coniano neologismi autoctoni alternativi a quelli inglesi e li promuovono, e mentre in Germania questo lavoro viene fatto da associazioni sorte dal basso come la VDS che pubblica annualmente l’Indice degli anglicismi con i loro sostitutivi, da noi non c’è nulla del genere, né di istituzionale né di privato (il dizionario AAA è solo una goccia). E il risultato è che da noi le alternative non esistono e siamo costretti a ricorrere agli anglicismi “di necessità”, mentre in Francia, per esempio, ricorrere all’inglese diventa una scelta sociolinguistica culturale o politica, come scrive la terminologa Maria Teresa Zanola, che nota come la reazione al franglais supportato dalle iniziative pubbliche e private ha favorito la coniazione di neologismi e l’evoluzione della lingua francese che è in questo modo piuttosto vitale, (12) al contrario dell’italiano che regredisce.
In Islanda, la figura del “neologista” esiste ufficialmente, e crea alternative agli anglicismi attraverso neoconiazioni che partono dalle radici endogene, cioè dalla propria lingua. Questi linguisti hanno il compito di rinnovare l’islandese e di tenerlo al passo con i tempi creando parole per ogni oggetto o concetto importato. In un primo tempo questi termini venivano pubblicati sui giornali, ma oggi circolano glossari cartacei e dizionari in Rete. E tutto ciò viene fatto formalmente da un apposito dipartimento dello Stato, nel Dipartimento della Pianificazione del Linguaggio che sorge in un istituto culturale nel centro della capitale.
E allora, quando si fa dell’inglese la soluzione alla comunicazione internazionale, quando lo si vende come una lingua che apparterrebbe “a tutti” e che ci unificherebbe, si omette di dire che questa “unificazione” si fa a scapito del plurilinguismo e che è un’unificazione che allo stesso tempo divide e crea barriere sociali. Che non è la lingua di tutti, ma quella dei popoli dominanti che hanno tutta la convenienza a esportarla come “universale” perché costituisce un indotto economico spropositato, perché dà loro un enorme vantaggio comunicativo e perché permette loro di non apprendere alcuna altra lingua e di destinare gli altissimi costi dello studio di una seconda lingua verso altre direzioni come la ricerca. E soprattutto si omette di raccontare anche quali sono gli effetti collaterali di questo globalese tanto esaltato.
Note
1) Cfr. Robert McCrum, William Cran, Robert MacNeil, La storia delle lingue inglesi, Zanichelli, Bologna 1992, p. 39.
2) English Vinglish, di Gauri Shinde (2012) interpretato dall’attrice Sridevi Kapoor, soprannominata la “Meryl Streep d’India”.
3) Ngũgĩ wa Thiong’o, Decolonizzare la mente, Jaka Book, Milano 2015.
4) Ivi, p. 16.
5) “Scrittori, ribelliamoci all’inglese”, di Pietro Veronese (intervista a Ngũgĩ wa Thiong’o), la Repubblica, 2 agosto 2019.
6) Claude Hagège, Morte e rinascita delle lingue. Diversità linguistica come patrimonio dell’umanità, Feltrinelli, Milano 2002, p. 7.
7) Ivi, p. 99.
8) Cfr. Tove Skutnabb-Kangas, “I diritti umani e le ingiustizie linguistiche. Un futuro per la diversità? Teorie, esperienze e strumenti”, in Come si è ristretto il mondo, a cura di Francesco Susi, Amando Editore, Roma 1999 (p. 85-114), p. 99.
9) Cfr. Fiona Zublin, “Iceland Fights to Protect Its Native Tongue From Siri”, in Ozy.com, 9/7/2018.
10) Cfr. Cristina Piotti “Islandese, una lingua a rischio estinzione”, IL – Il maschile del Sole 24 ore, 21/02/2019. 10
11) Ivi.
12) Maria Teresa Zanola, “Les anglicismes et le français du XXIe siècle : La fin du franglais ?”, Synergies Italie, n. 4, 2008, p. 95.
PS 2023
[Questo articolo è stato ricostruito dopo un attacco informatico che lo aveva cancellato. I collegamenti e i commenti originali sono perduti.]