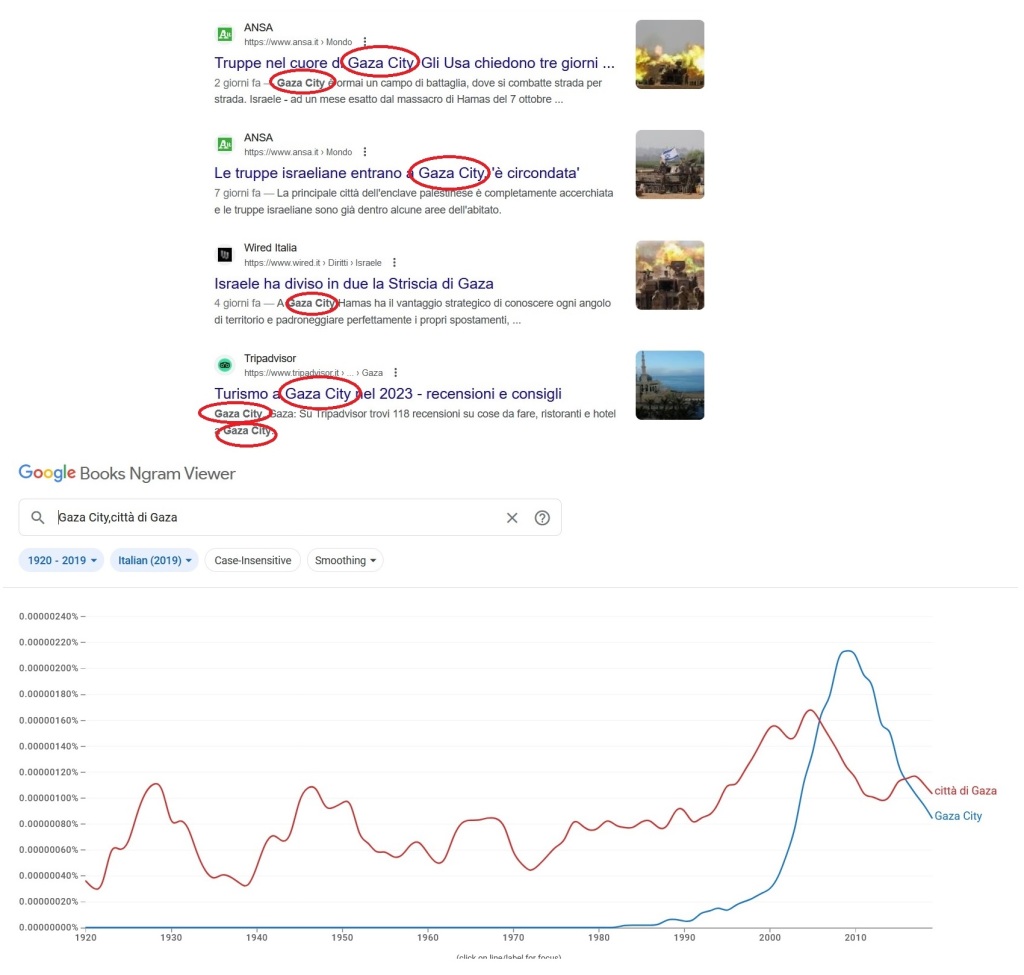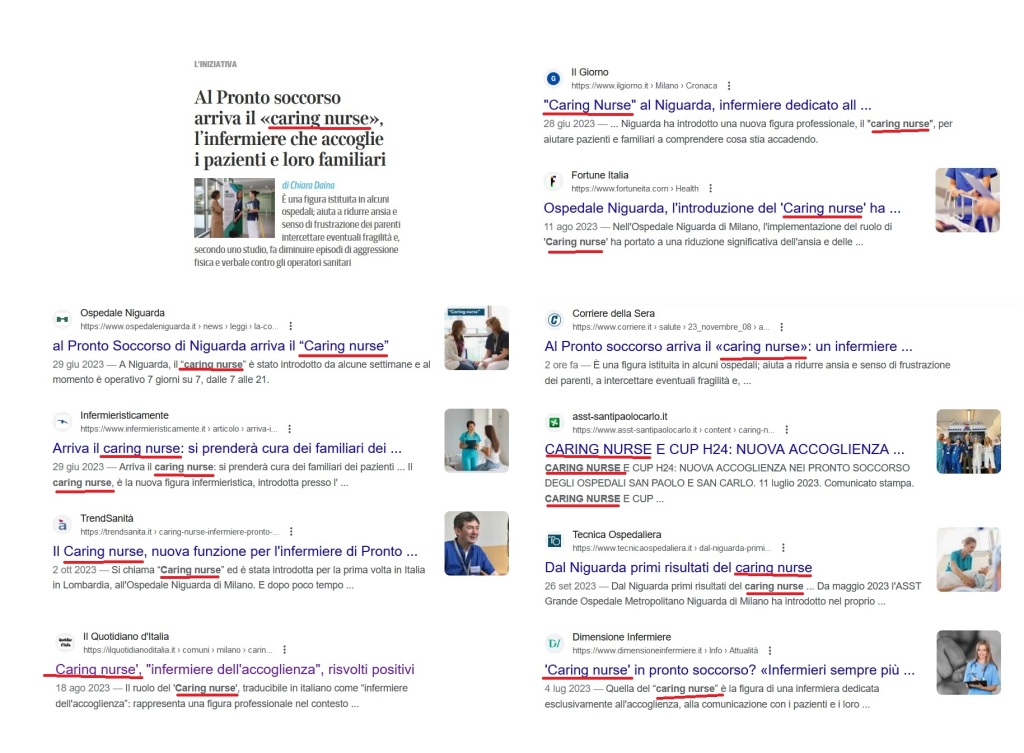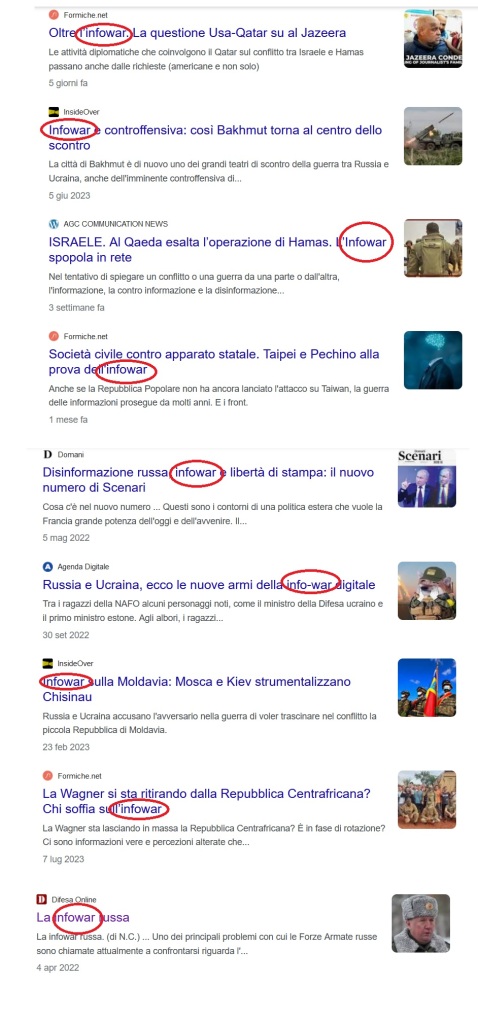Di Antonio Zoppetti
Quando ero piccolo nella bella stagione scorrazzavo con i miei amici ai giardinetti, e in alcuni c’erano anche i parchi giochi con lo scivolo e l’altalena. Facevo la raccolta di adesivi e di figurine, ero un accanito lettore dell’Uomo Ragno, e mi ero fatto regalare il pupazzetto con cui giocavo. Negli anni Settanta, tra le novità per i ragazzi, erano apparsi i primi videogiochi che si trovavano nei bar, mentre al cinema spopolava Guerre stellari.
Oggi queste stesse cose si dicono in inglese. I ragazzi non sanno cosa siano gli adesivi, perché li chiamano sticker(s), hanno a che fare con Spiderman, la saga di Star Wars e il Monopoly; i bambolotti si chiamano action figure – un nome in inglese che li nobilita e permette di bramarli anche da adulti senza la vergogna di giocare con le bambole – mentre la raccolta di figurine è diventata anche card collection e i videogiochi sono quasi sempre solo videogame.

Da qualche tempo è in atto un restyling linguistico, oltre che sociale, che prevede l’anglificazione anche dei parchi giochi che si vogliono far diventare play street (talvolta scritto tutto attaccato: playstreet).
Che cos’è una play street?
Non c’è bisogno di spiegarlo, in fin dei conti, perché rispetto agli anni Settanta entrambe le radici che compongono questa espressione sono entrate nella disponibilità di tutti.
Play non è più solo il comando di avvio che leggiamo sul pulsante di certi elettrodomestici, è gioco, e ci sono la playstation, i multiplayer, il cosplay e i cosplayer, visto che un giocatore è ormai detto player in senso tecnico e figurato, e un gioco di ruolo è role play. Il regista della pallacanestro divenuta basket è un playmaker, le finali sono playoff o playout; c’è il display, il playback, la playlist, il replay… che si aggiungono ai più datati playboy e playgirl affiancati da playmate (ragazze copertina), mentre vengono riesumati i vecchi long play di vinile che sembravano destinati a tramontare.
Sul fronte stradale, se una volta c’era solo Wall Street, oggi la cucina di strada è street food, i graffitari – detti writer(s) – sono street artist e fanno street art, e si parla anche di street culture, di streetwear o streetstyle, di street show e street parade.
Gli anglicismi non sono “prestiti” isolati, né di lusso né di necessità. Sono trapianti di suoni, significati e concetti che si allargano nel nostro lessico strutturandosi in famiglie e facendo tabula rasa dell’italiano. Sono tra loro collegati e si rinforzano l’uno con l’altro. La metafora della lingua come un sistema biologico – la lingua viva e le lingue morte – è più che mai calzante. Ma mentre ci si preoccupa per la proliferazione del granchio blu che comporta devastazioni ecologiche, non si sentono analoghe preoccupazioni per il nostro idioma. Eppure il nostro ecosistema linguistico è travolto da parole che provengono da un sola lingua: l’angloamericano, la lingua dei Paesi dominanti che entra in conflitto con le lingue locali, e che nel caso dell’italiano produce uno tsunami particolarmente devastante, perché la nostra unità linguistica è recentissima, è una conquista del Novecento, ed è anche fragile.
Come se non bastasse, non solo siamo accecati da un complesso di inferiorità italofobo – una vera e propria anglomania compulsiva – che ci fa preferire le parole inglesi, ma quel che è peggio è che in Italia non esiste alcun punto di riferimento normativo della lingua, e l’Accademia della Crusca si vanta di non essere prescrittiva come lo sono invece le accademie spagnole e francese.
In Francia esistono delle leggi che tutelano il loro patrimonio linguistico davanti all’inglese, e l’accademia interviene, come le accademie ispaniche, per indicare quali sono le giuste parole autoctone. In quei Paesi esistono banche dati terminologiche – per esempio quella del Quebec – che ufficializzano la nomenclatura di ogni cosa nella propria lingua. In Islanda esiste la figura del neologista di Stato che crea sostitutivi agli anglicismi con radice endogene, in Israele c’è un’accademia che conia i termini nuovi con cui ha riattualizzato l’ebraico antico, una lingua che è stata rivitalizzata; persino i cattolici aggiornano il latino ecclesiastico creando neologismi come breviloquium per tweet, e simili commissioni esistono anche per attualizzare l’esperanto e mantenerlo vivo. Mentre la nostra Crusca bolla l’idea di un Consiglio Superiore della Lingua Italiana (CSLI) come una follia concettuale, analoghi organi esistono, sono normali e funzionano in tantissimi Paesi, e forse l’unica vera follia è l’appellarsi a un presunto liberalismo linguistico che si trasforma in anarchia, in mancanza di punti di riferimento, e in un “far west” dove vige la legge del più forte, l’inglese, of course. Stare a guardare tutto ciò senza intervenire non è un atteggiamento liberale, ma criminale.
Play street e scrapbooking
Le prove tecniche di sostituzione linguistica e dell’introduzione del “nuovo” concetto di play street a Milano risalgono al 2021, quando il Comune ha deciso di chiamare così un progetto intenzionato a spacciare come una novità che richiederebbe un nuovo nome: “Il Comune di Milano ha firmato dei patti di collaborazione per sperimentare la prima forma di ‘play street‘ a Milano, spazio in città dedicato al gioco.”

La comunicazione era incentrata sull’apologia del cambiamento e della trasformazione urbana, e cosa c’è di meglio del trasformare ogni cambiamento sociale anche in un cambiamento linguistico a base inglese?
“Una ‘play street’ o un ‘play ground’ è uno spazio in città dedicato al gioco, piuttosto che al traffico”, si leggeva in un articolo promozionale di allora. E subito dopo scattava la consueta precisazione “non-è-proprista” volta a dare un definizione del “nuovo” concetto: “Non sono parchi o luoghi limitati da cancelli, sono vere e proprie strade che vengono trasformate per rispondere alle esigenze delle persone e alle misure di sicurezza che la pandemia obbliga a rispettare.” Eccola la straordinaria novità sbandierata tra il suono delle unghie che stridono nel tentativo di arrampicarsi sugli specchi: i parchi giochi sono vecchiume, sono quelli di una volta, recintati e delimitati, mentre una play street (play ground per fortuna non ha attecchito, almeno finora) è un nuovo intraducibile concetto che esprime tutt’altra cosa. Perché questa presunta novità debba essere espressa in inglese non viene mai detto, e si dà per scontato, visto che la metà dei neologismi del nuovo millennio è in inglese crudo.
Una lingua viva e sana deve cambiare per stare al passo con i cambiamenti sociali, ma purtroppo l’italiano non è più in grado di farlo con le sue parole, che vengono relegate al passato, e l’unica cosa che sappiamo fare è quella di sostituirle con l’inglese, come se fosse normale.
Quando ero uno studente di liceo ero orgoglioso della mia Smemoranda, un tipo di diario scolastico alternativo che andava per la maggiore, a quei tempi. Più che usarlo come agenda dei compiti, ogni studente lo personalizzava incollando fotografie, disegni, decorandolo con glosse, schizzi, testi di canzoni, e facendolo diventare quasi un libro d’artista, al punto che sfogliare i diari dei compagni, e anche scambiarsi le personalizzazioni era una pratica comune.

Oggi a tutto ciò si vuole dare un nome, naturalmente in inglese, e la riconcettualizzazione di questa antica abitudine non si chiama libro dei ritagli o diario d’artista, non si chiama nemmeno più decoupage, tecnica che non si applica a un diario, ma solo ad altre suppelletili. La new-arte si chiama scrapbooking, e presumo che i singoli “libri” si chiamino scrapbook, così come i nuovi parchi giochi non sono né strade in gioco né giocainstrada, sono solo play street, perché l’italiano ha smesso di produrre i propri neologismi.
Ogni ammodernamento di vecchi concetti è ribattezzato con il lessico inglese. L’anglomane punta a denominare in inglese ogni novità, che di solito è una novità presunta, e una riscrittura della storia. La menzogna sta nella definizione basata sul “nuovismo”. Ma sono “necessari” questi nuovi nomi?
Un tempo il telefono era in bachelite, rigorosamente nero, fisso e appeso al muro. Si telefonava in piedi, in un angolino di qualche corridoio casalingo come nelle vecchie cabine telefoniche. Poi sono arrivati quelli da scrivania, spesso grigi, che come gli altri avevano la rotellina per comporre il numero, che in qualche caso i genitori ostili alle lunghe – e allora costose – telefonate adolescenziali bloccavano con un lucchetto. I ragazzi più sgamati avevano imparato ad agire direttamente sul perno della rotella con una pinzetta che permetteva di far scattare il meccanismo anche se la rotella era bloccata. Poi sono arrivati i telefoni a tastiera. Impazzava il modello Sirio, in vari colori, e più avanti le forme dei telefoni si sono differenziate e sbizzarrite. Mia zia aveva un tamarrissimo telefono a forma di Topolino che reggeva in mano la cornetta, e a casa di amici avevo visto addirittura un telefono rosso a forma di bocca.

Nonostante queste trasformazioni si trattava sempre del telefono. A nessuno sarebbe venuto in mente di usare un altro nome da associare ai modelli che si trasformavano e si differenziavano in ogni modo. Almeno fino a quando non sono spuntati i primi cordeless, invece dei telefoni senza fili, e poi sono arrivati gli smartphone a creare la consueta cesura con il passato che sta trasformando l’italiano in itanglese (e anche less e smart sono radici prolifiche).
Per chi è interessato, venerdì 24, alle 18, parlerò di queste e altre cose al circolo degli esperantisti di Milano in via Marsala 10 (MM Moscova), e presenterò il libro Lo tsunami degli anglicismi. Gli effetti collaterali della globalizzazione linguistica (goWare 2023).
Questa sera, invece, alle 20, sull’emittente di Pordenone il13 andrà in onda l’intervista che mi ha fatto la giornalista Marianna Maiorino.