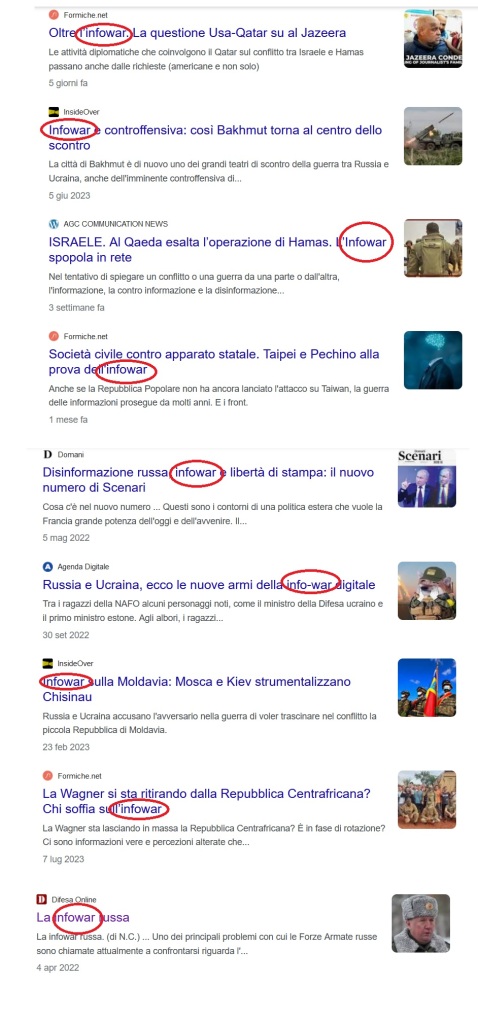Di Antonio Zoppetti
La notizia che mi ha segnalato ieri l’attivista dell’italiano Marco Zomer riguarda la “svolta” di una scuola secondaria di Torino, l’Istituto Avogadro, che ha deciso di introdurre nella sua offerta formativa i corsi in lingua inglese invece che in italiano. I percorsi di studio sono due: il liceo scientifico dove la biologia, la chimica, la fisica e l’informatica verranno insegnate in inglese; e l’indirizzo tecnico dove l’inglese sarà la lingua di apprendimento “solo” di informatica e fisica. Come se non bastasse, l’insegnamento dell’inglese già previsto e obbligatorio verrà aumentato di due ore.

Il modo in cui l’articolo della Stampa riporta la notizia è il solito, si esaltano queste decisioni in modo acritico per propagandarle, invece di analizzarle, con la volontà di giustificare e diffondere la visione anglomane che la nostra intellighenzia ha fatto sua. E così leggiamo che la scuola “guarda al futuro” (cioè il futuro coloniale dell’Italia), perché dal prossimo anno includerà “i programmi Cambridge”. A dire il vero questi programmi servono per imparare l’inglese, non per insegnare le materie scientifiche, e andrebbe almeno specificato. Ma il pezzo, il cui incipit è un solenne “Torino chiama Cambridge” punta a mostrare che in questo modo la scuola torinese si eleva al prestigio di quella inglese, e sottolinea la grande innovazione per l’indirizzo tecnico, perché avrebbe solo quattro precedenti in tutta Italia, mentre al liceo scientifico è forse una prassi meno rara.
Le argomentazioni didattiche o pedagogiche sottostanti hanno lo spessore di una televendita di cinture dimagranti eccezionali perché vengono dall’America, a partire dai virgolettati della professoressa Elena Vietti che spiega come la “metodologia Cambridge” favorisca lo sviluppo delle tecniche di problem solving “oltre ovviamente un potenziamento della lingua stessa”. E qui infila la prima evidente castroneria, perché se vogliamo imitare il modello di formazione anglosassone dobbiamo appunto capire una cosa molto semplice: lì potenziano la propria lingua, non quella degli altri. Se Torino chiama Cambridge, va detto che Cambridge non chiama né Torino, né Parigi, né Madrid, né Berlino né alcun altro. A Cambridge non si studiano le materie in francese, tedesco o italiano – forse alla prof sfugge questo piccolo trascurabile particolare – e nei sistemi scolastici angloamericani le lingue straniere non sono contemplate, o comunque non sono obbligatorie, e quando sono previste hanno un ruolo marginale. Ma nel processo di alienazione linguistica in atto – l’abbandono dell’italiano per passare all’inglese – non si racconta che mentre tutta l’Europa spende una fortuna per insegnare l’inglese (lingua di fatto extracomunitaria) e formare le nuove generazioni bilingui a base inglese sin dalle elementari, gli inglesi e gli americani non hanno questi costi, visto che preferiscono che tutto il mondo impari e usi la loro lingua naturale.
Ora, per chiamare le cose con il loro nome, tutto ciò avviene all’insegna del colonialismo linguistico. Non stupisce che gli anglofoni, maestri del colonialismo e anche di quello che un tempo si chiamava imperialismo, spingano in questa direzione che comporta interessi economici e strategici per loro spropositati. Quello che stupisce è che in Italia non lo si capisca o si faccia finta di non capirlo. Colpisce il servilismo con cui ci zerbiniamo davanti alla “lingua dei padroni” e alla dittatura dell’inglese in un’alienazione culturale che distrugge la nostra lingua e cultura.
Dal punto di vista didattico, la citata professoressa spiega l’intento di voler conciliare l’approccio all’istruzione anglosassone di taglio molto pragmatico con la tradizione italiana più “teorica”, ma bisogna specificare che dietro la nostra “teoria” c’è – o forse c’era – un ben diverso criterio che tende a considerare le cose da un punto di vista storico e anche critico, che è molto distante da quello per esempio tipicamente americano che in nome di questo scellerato “problem solving”, già introdotto a forza nelle scuole come criterio di valutazione degli studenti, si limita il più delle volte a fornire nozioni non sottoposte ad analisi critiche né storicizzate. E in questo passaggio a un sistema “misto” (dove però c’è solo la lingua inglese) l’inglese farà da “link” alle materie: collegamento è parola della veterolingua che si vuole cancellare, ma si potrebbe dire forse anche hub, invece di snodo o raccordo (l’itanglese nella sua ricchezza ci sta fornendo sempre più sinonimi). Come se senza questo link, le materie fossero percepire come disgiunte, e come se questo collegamento non si possa fare nella nostra lingua nativa!
Il livello di queste dichiarazioni è sconcertante, e ancora più sconcertante è come i giornali lo ripetano facendolo passare come normale. Questo conciliare i due metodi in modo appunto astratto e teorico ricorda certe caricature con cui si dice di voler essere ecologici ma senza rinunciare al suv, o di volere incentivare prodotti locali a chilometro zero ma anche la Coca Cola. Nella realtà, dietro le proposte di anglificazione della scuola l’obiettivo è solo uno: l’imposizione dell’inglese che diventa LA materia più importante e il cardine attorno al quale si vuol far ruotare l’istruzione. Lo si vede dal bocconcino più goloso dell’operazione che include appunto l’ottenere la certificazione Igcse, la ciliegina che è il vero obiettivo dell’offerta.
Ma l’italiano dov’è? Che ruolo e che peso ha in questo percorso? Come mai le nuove scuole-aziende americanizzate o cambridgizzate e il nuovo sistema scolastico che viene smantellato sfornano studenti con sempre più problemi di analfabetismo di ritorno o funzionale?
Sembra che sul piatto della formazione la pietanza forte sia solo l’inglese, come se tutto il resto forse un contorno di cui si può fare anche a meno. E colpisce l’affermazione di un’altra professoressa che con orgoglio spiega che la nuova offerta anglomane non ha richiesto nuovi docenti, perché quelli in carica sono già patentati del livello C1 e C2 di inglese. Dietro questo fiorellino da mettere all’occhiello non si mette in luce la preparazione, la competenza o la bravura dell’organico, ma solo la sua conoscenza della lingua superiore. Come se fosse questo il requisito da propagandare negli immancabili “Open day” che servono a reclutare gli studenti.
Il numero di Avogadro
La dirigente scolastica dell’Istituto, nello spiegare che si tratta di una sperimentazione solo avviata, anticipa che per il momento ci si aspetta un numero di studenti e classi contenuto, e dalle adesioni dipenderà il futuro allargamento della proposta ad altri indirizzi e classi. La mia speranza è che iniziative di questo tipo falliscano miseramente, e che non si raggiunga il “numero di Avogadro” necessario per continuarli. Più realisticamente so bene che non andrà a questo modo, perché l’anglificazione della scuola nel nuovo millennio si sta allargando in maniera preoccupante.
Uno dei primi segnali è partito proprio da Torino, quando il Politecnico ha deciso di incentivare i corsi in inglese nell’anno accademico 2007-2008 attraverso l’iscrizione gratuita per il primo anno, discriminando di fatto i corsi in italiano che invece si pagavano. Pochi anni dopo, nel 2012, il Politecnico di Milano si è spinto ben oltre decidendo di estromettere la nostra lingua dalla formazione universitaria per erogare corsi solo in inglese. Anche in questo caso ci sono state vicende giudiziarie infinite, ma benché sulla carta sia stata riconosciuta una teorica “primazia dell’italiano”, di fatto l’ateneo continua a erogare corsi quasi solo in inglese. E così mentre questo modello si allarga, e recentemente anche la Bocconi di Milano ha preso la medesima direzione, oggi si abbassa l’asticella includendo anche le scuole secondarie, che sono il prossimo terreno di conquista. Nei Paesi scandinavi, dove l’anglificazione è stata da tempo introdotta e sperimentata, si assiste a una marcia indietro perché si è visto che insegnare in inglese si trasforma in un processo sottrattivo, non aggiuntivo. Insegnare in un’altra lingua comporta la perdita e la riduzione della terminologia nella lingua nativa, induce alla semplificazione dei concetti e dei ragionamenti perché si esprimono con più difficoltà, spinge a pensare in inglese, che invece di aggiungersi alla lingua di partenza finisce per fagocitarla. Noi, al contrario stiamo andando in questa direzione suicida in modo becero, acritico e coloniale. Le nefaste conseguenze di questi approcci sono state denunciate da autori africani come Ngugi wa Thiong’o che le hanno subite: lì, le scuole coloniali in lingua inglese hanno non solo contribuito all’abbandono delle lingue indigene, ma hanno soprattutto creato barriere culturali: chi non sapeva l’inglese non poteva accedere alle scuole che imponevano quella lingua e in quella lingua insegnavano. L’inglese ha creato una diglossia tra lingua della cultura e lingua del popolo che da noi apparteneva al Medioevo, quando il latino era la lingua appunto della scuola e della scrittura e il volgare delle massi analfabete. E noi, oggi, in nome di un supposto “internazionalismo” che viene fatto coincidere in modo surrettizio con il parlare in inglese, stiamo costruendoci da soli analoghe scuole coloniali per formare le future generazioni. Così, mentre l’itanglese diviene la lingua modello del linguaggio della scuola e del Ministero dell’Istruzione, l’inglese puro diviene la lingua della nuova cultura, in una svolta linguicista che discrimina la nostra storia e cultura.
Ma a raccontare queste cose, o per lo meno a mostrare l’altra faccia della medaglia dell’anglificazione, affinché ognuno possa fare le sue scelte in modo consapevole, non sono i giornali, né i politici, né gli intellettuali (a parte sparute eccezioni di qualche “dissidente”), sono più spesso i lettori. E Marco Zomer, agguerrito attivista dell’italiano, è riuscito a fare arrivare la sua voce al giornale, seppur in un trafiletto in cui le sue riflessioni sono state riassunte e semplificate.
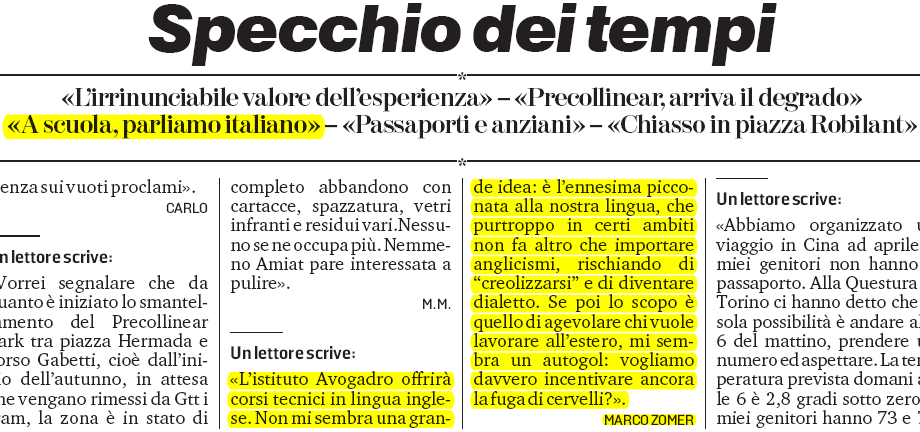
L’anglificazione della scuola è il nuovo terreno di conquista che nei prossimi anni emergerà e si allargherà, ma invece di produrre riflessioni serie e dibattiti, viene dato per scontato come “il futuro” ineluttabile, un futuro dove l’italiano finirà per diventare un dialetto.