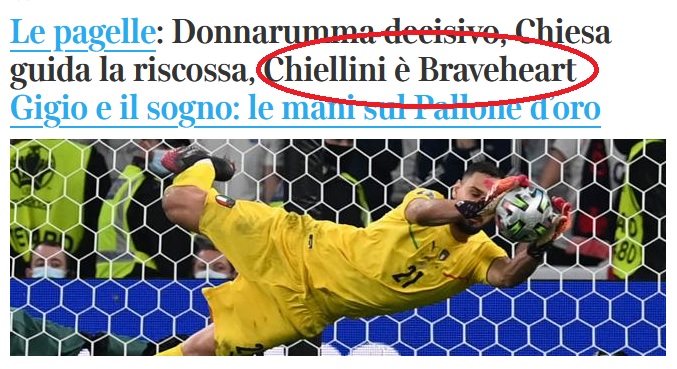Di Antonio Zoppetti
L’altro giorno, su La Repubblica, nella rubrica Moda e Beauty si parlava dello sharenting, il fenomeno dei genitori che pubblicano le foto dei figli in Rete, anzi sui social, che in inglese sarebbe social network (altrimenti significa solo sociale) ma che noi usiamo al posto di piattaforme sociali.

Sharenting circola almeno dal 2016, e nel 2020 un giornalista espertone ci ha scritto pure un libro (Gianluigi Bonanomi, Sharenting. Genitori e rischi della sovraesposizione dei figli online, Mondadori 2020). A noi non resta che dire così, visto che nessuno è capace di inventare parole nuove, né di usare quelle vecchie, nel pappagallismo italiano che non fa che scimmiottare ogni cosa che arriva dagli Stati Uniti, in particolare le fesserie.
Inutile dire che questa parola-concetto non esiste sui mezzi di informazione francesi e spagnoli, dove i social sono le reti sociali e gli influencer sono infuenti, perché fuori dall’Italia è in voga una bizzarra consuetudine, quella di usare la propria lingua, in linea di massima, senza che nessuno se ne vergogni. Ma noi siamo troppo avanti nel nostro suicidio linguistico e culturale.
Il plogging
E così capita che CemAmbiente di Cavenago Brianza lanci l’iniziativa del plogging, ottimo esempio di distruzione delle parole attraverso la sostituzione con quelle inglesi, in un lavaggio del cervello che cancella il passato, la storia e crea nuove realtà. L’attenzione per l’ecologia linguistica è inesistente in queste iniziative che proteggono l’ambiente mandando in rovina l’italiano.

Quando ero ragazzo il mio vicino di casa partecipava ogni estate ai campi per ripulire i parchi dai rifiuti. Le iniziative per ripulire l’ambiente sono un concetto piuttosto datato e diffuso. “Una camminata per pulire le strade” si può leggere in un articolo del 2012 su Il Tirreno che riferisce del progetto “Puliamo le nostre strade” organizzato dall’associazione A piedi nudi di un piccolo Comune. In italiano ci sono iniziative anche più recenti come la “Staffetta sull’Adda per ripulire i bordi del fiume e l’Alzaia dai rifiuti”, ma la differenza con il passato è che oggi tutto ciò è etichettato all’insegna del plastic free, visto che siamo incapaci di dire senza plastica.
“Ma queste iniziative sono altra cosa rispetto al plogging, che non è proprio come….”, dirà subito il “non-è-proprista” pronto a difendere le sfumature dell’inglese e dello pseudoninglese. Naturalmente questo atteggiamento porta il più delle volte a dire un gran numero di idiozie.

Il rispetto della natura si ritrova nei vecchi manuali di montagna, che tra le regole auree prescrivevano di non lasciare rifiuti e tracce del proprio passaggio, e spesso incentivano a raccogliere i rifiuti altrui, durante le escursioni. Un appassionato di montagna comeFabrizio Bellucci, detto Bicio, sul suo sito Zaino in spalla, scriveva (con tanto di logo oggi chiamato “kit del plogger”): “Nel mio zaino porto sempre un sacchetto di plastica (sì, proprio uno di quelli che inquinano maggiormente) e un guanto riciclati tra quelli utilizzati per l’acquisto di frutta e verdura nei supermercati. Durante la camminata in montagna, se vedo cartacce, lattine, pezzi di plastica abbandonati, mi infilo il guanto e li raccolgo nel sacchetto, che porterò giù a valle. Oltre all’oggettivo vantaggio di sgomberare i sentieri dai rifiuti, se qualche escursionista ci vede durante la raccolta, come minimo eviterà di gettare rifiuti a sua volta e magari seguirà il nostro esempio alla prossima occasione. (…) Il bello è che questa raccolta non avviene una volta all’anno in occasione della festa dei sentieri, ma è un piccolo gesto che è entrato ormai a far parte del nostro modo di andare in montagna.”
La cancellazione del passato
Cancelliamo il passato, riscriviamo la storia, costruiamo una nuova realtà è usiamo l’inglese. Presto fatto. Buttiamo l’italiano e passiamo al plogging. “Il nuovo trend nato in Svezia, unisce in sé le due parole ‘jogging’ e ‘plocka’ che è svedese e significa ‘raccogliere”. L’idea è semplice: interrompere la corsa o camminata con piegamenti e stretching fa bene al corpo e raccogliere contemporaneamente i rifiuti da terra aiuta l’ambiente.”
Plogging è perfetto da vendere come un nuovo concetto della newlingua. Suona inglese, si appoggia ai tanti “ing” che ormai abbiamo fatto nostri (shopping, working, trekking…), e dunque i giornali lo diffondono così: “Plogging, correre e raccogliere rifiuti” si legge sulla rubrica Vivere Green di ANSA (7 maggio 2018); “Sport e green: impazza il plogging, raccogliere rifiuti correndo” (Il Sole 24 ORE, 5 aprile 2021)…
Prima dell’arrivo del plogging c’erano altri modi per reinventare l’acqua calda facendola sembrare un concetto nuovo e inglese. Si può citare il “Collect Waste Walk: camminare e raccogliere rifiuti” (6 marzo 2019), spacciato come la geniale idea di un salentino (ma se si esprimesse non dico in italiano ma almeno nel dialetto locale, non sarebbe meglio?) “che ha inventato un nuovo sport che unisce la passeggiata all’attività di raccolta rifiuti”.
Oppure si può parlare più semplicemente di ecotrekkig: “Passeggiare e raccogliere rifiuti in montagna: così nasce l’ecotrekking”, una parola usata anche dall’italianissimo Chianti Green, che introduce il concetto dei “cittadini walk & clean”.
L’elenco di questi esempi è sterminato.
Il lessico dell’anglonuovismo
Il problema non sono le singole espressioni, talvolta passeggere, talvolta no. Il problema è la logica che c’è sotto, ed è questa che sta facendo morire l’italiano. Si rinnova tutto, anche le cose più vecchie, usando qualsiasi cosa che suoni in inglese. E allora nascono gli hub vaccinali invece dei centri, i covid hospital invece degli ospedali covid, i cluster invece dei focolai, i no vax invece degli storici antivaccinisti, seguiti dai no mask (ennesima espressione assente nel francese e nello spagnolo)… È la panspermia dell’inglese che ci bombarda quotidianamente con migliaia e migliaia di anglicismi, con la stessa tecnica della riproduzione delle ostriche che sparano migliaia e migliaia di larve. La maggior parte non sopravvivono, sono passeggere; ma altre attecchiscono, e poi si riproducono (se c’è il plogging c’è anche il plogger). E così il trekking e il trekker hanno la meglio su escursionismo ed escursionista, dove gli sport all’aperto sono outdoor, la corsa è il running, il jogging, persino il footing… in una catena di anglicismi che si amplia a scapito delle parole italiane che regrediscono (se la corsa è jogging poi nasce il plogging).
L’altro giorno una mia amica mi ha avvertito che era in ritardo perché il fixing dell’apparato acustico che stava acquistando andava per le lunghe. Si tratta semplicemente della fase di personalizzazione e adattamento che gli esperti chiamavano in un più solenne inglese, ma che si potrebbe dire anche customizzazione, in altri contesti. L’ortopedico mi ha detto che devo fare stretching, non esercizi di allungamento. Il nostro governo ha deciso di inseguire il modello di Macron che prevede l’obbligo del certificato verde, ma i giornali lo chiamano green pass, anche se Macron lo chiama passe sanitaire. E mentre i giornali spagnoli parlano di certificato covid, da noi c’è solo il green pass, che in inglese chiamano healt pass, cioè passaporto sanitario. Tutti gli apparati mediatici da noi continuano a tradurre il “certificato verde” in questa sovralingua itanglese, assurda e ridicola. Green pass è un’invenzione giornalistica evoluta dal covid pass. La sensazione è quella di vivere in un Paese occupato. E dobbiamo chiederci: chi ci sta occupando?

Il green pass sui giornali in Italia, e come si dice in Francia, Spagna e Regno Unito.
Il broccolino 2.0
Gli immigrati italiani di New York di primo Novecento chiamavano la lavatrice (washing machine) “vascìnga mascìne” nell’italiano broccolino. Quell’idioletto – cioè la lingua ibrida di una piccola comunità – era fatto di adattamenti delle parole inglesi ai suoni italiani, visto che i nostri connazionali a Brooklyn non padroneggiavano l’inglese, e il nome di quel quartiere era così simile a “broccolo” che bastava dire così per farsi intendere. Per cui il lavoro (job) diventava “giobba” e i negozi (shop) “scioppa”.
Un secolo dopo questo italiano broccolino è scomparso, ma è la nostra lingua nazionale che si è trasformata in una sorta di broccolino 2.0: si chiama itanglese ed è parlato in Italia dagli italiani, non dagli immigrati all’estero. Tutto si è ribaltato, non adattiamo più i suoni inglesi a quelli italiani, ma viceversa. Dunque il lavoro è ormai direttamente job o work a seconda dei contesti, e i negozi sono diventati shop, ma anche store. A buttar via le nostre parole per sostituirle con quelle angloamericane non sono più gli emigrati “ignoranti”, ma i giornalisti, gli intellettuali e la nostra intera classe dirigente, cioè quelli che hanno il potere di fare la lingua, quelli che un tempo hanno unificato l’italiano e oggi lo stanno distruggendo. Sono i coloni e i collaborazionisti di un nuovo regime linguistico che si vuole imporre. Che è fatto di parole inglesi importate ma anche di neo-coniazioni pseudo-inglesi autoctone.
L’englishwahing: il lavaggio del cervello attraverso l’inglese
Dalla “vascinga mascine” siamo passati al whitewashing (white = bianco e washing = lavaggio) per indicare il dare una sbiancata ai protagonisti dei film, cioè la tendenza a utilizzare attori bianchi per ruoli che storicamente spetterebbero ad altre etnie. Poiché gli anglicismi non sono isolati e ognuno tira l’altro come le ciliegie, si parla anche di greenwashing per indicare l’ecologia di facciata per esempio di certe pubblicità o politiche aziendali, e anche di pinkwashing per indicare lo pseudo-femminismo paternalistico e demagogico, l’ipocrisia rosa, potremmo chiamarla, se non fossimo colonizzati. Il punto è che nessuno vuole ricorrere all’italiano, e forse non ne siamo più capaci.
Questo fenomeno patologico che sta facendo morire la nostra lingua si potrebbe forse chiamare Englishwhasching, per usare il linguaggio di chi la sta distruggendo e fare in modo che capisca il problema. Dopo l’epoca in cui Manzoni aveva sciacquato i panni in Arno, oggi i nuovi centri di irradiazione della lingua preferiscono immergerli nelle acque del Mississipi, più che del Tamigi. È il lavaggio del cervello attraverso le parole-concetti in inglese.
La newlingua orwelliana
Questa newlingua ibrida ricorda in modo impressionante la neolingua di 1984 di Orwell, quella che il Grande fratello voleva realizzare con la creazione del dizionario della Novalingua. Nella sua Teoria della dittatura (Ponte della grazie, 2020), Michel Onfary analizza nel dettaglio questo progetto, punto per punto. La neolingua punta alla distruzione delle parole, alla cancellazione del passato, a riscrivere la storia per creare una nuova realtà. Esattamente quello che stiamo facendo noi.
Al contrario dello scenario owelliano, a imporre la newlingua non c’è una dittatura, ma una “onorevole gara” a sostituire le parole, che ricorda il meccanismo ben descritto da Tacito nell’Agricola. Il merito di questo condottiero romano non è stato tanto nella conquista della Britannia – spiegava Tacito – bensì nell’essere riuscito a tenerla colonizzandola culturalmente. È riuscito a far bramare i costumi, la cultura e la lingua degli invasori, in modo che coloro che prima sdegnavano il linguaggio romano alla fine ne ammirassero l’eloquenza. Agricola riuscì in questa impresa soprattutto coinvolgendo i figli dei capi tribù, cioè la classe dirigente, per tradurre tutto in termini più moderni. “Gl’inesperti chiamavan ciò cultura, mentre era parte di servaggio” conclude Tacito.
Oggi assistiamo allo stesso meccanismo, ma sono i discendenti dei Britanni a soggiogarci con le loro “fogge”, i loro costumi, la loro cultura e la loro lingua.
Non ci sono eserciti e carri-armati a occupare il nostro Paese, ci sono le nuove strategie che aveva lucidamente compreso Churchill: “Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono quelli della mente.”
Questo disegno figlio del colonialismo inglese è stato poi realizzato dagli Stati Uniti. Le leve principali sono due: l’espansione delle multinazionali e della loro lingua, e la creazione del mito americano.
Dal mito del tu vuo’ fa’ l’americano alla realizzazione del “siamo tutti americani”
Naturalmente non c’è alcun complotto e nessuna sala dei bottoni dove queste cose vengono determinate. C’è una strategia più simile ai meccanismi della selezione naturale. Quando un esercito di cavallette invade un territorio non è perché il re delle cavallette lo ha ordinato loro. Semplicemente, migliaia di individui si muovono seguendo tutti la stessa pulsione e lo stesso obiettivo. Le multinazionali si espandono alla ricerca del profitto in tutto il mondo, imponendo allo stesso tempo la loro lingua e la loro terminologia (insieme alla loro logica) attraverso la pubblicità e le strategie di conquista. Nelle vetrine dalle insegne in inglese vediamo le sneaker, il black friday, le etichette con gli special prize… quando diciamo decoder invece di decodificatore, ripetiamo quello che leggiamo sulle scatole dei prodotti che compriamo. Le interfacce informatiche ci ammaestrano con i loro snippet, widget, timeline, homepage, link, download…
Il mondo del lavoro parla inglese, la cultura è ormai identificata con quella anglo-americana (non avrai altra cultura all’infuori di me!), che usa la terminologia inglese, dal cinema alle scienze sociali, dal marketing allo sport, dalla scienza alla tecnologia… E in questo contesto anche la scuola parla (e dunque forma) in itanglese e ci sono università che erogano ormai i corsi in inglese, mentre l’Europa punta all’inglese come lingua sovranazionale (alla faccia dei principi costituenti basati sul plurilinguismo) con i documenti bilingui a base inglese e altri subdoli analoghi provvedimenti. Dall’albertosordità del tu vuo’ fa’ ‘americano siamo passati al “siamo tutti americani” con cui si è aperto simbolicamente il nuovo Millennio.
Al contrario di ciò che avviene in Francia e in Spagna, questo inarrestabile fenomeno non è controbilanciato da alcuna pressione interna contraria. In Italia non ci sono né leggi, né accademie o associazioni linguistiche a tutela della nostra lingua. Accecati dal nuovo modello americano globalizzato, agevoliamo dall’interno la nostra distruzione culturale, e dunque linguistica. E ce ne compiaciamo.
PS 2023
[Questo articolo è stato ricostruito dopo un attacco informatico che lo aveva cancellato. I collegamenti e i commenti originali sono perduti.]