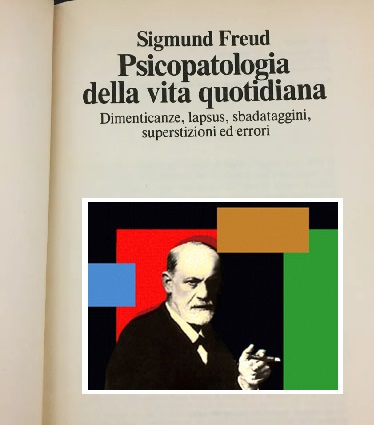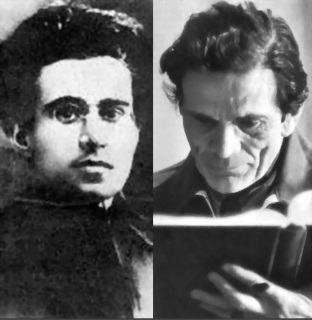Di Antonio Zoppetti
Il ruolo dei mezzi di informazione non è solo quello di offrire notizie, ma anche di diffondere le novità lessicali. È grazie alla loro funzione sociale di “centri di irradiazione della lingua” (per dirla con Gramsci e Pasolini) se ci siamo arricchiti di tante nuove parole come fake news, lockdown, green pass (sull’attestato denominato “certificazione verde”) e via dicendo.
La lettura dei quotidiani è dunque utile anche per imparare la newlingua chiamata itanglese che, al contrario della veterolingua di impostazione dantesca, ci permette di rimanere al passo con i tempi e con la modernità. I lessicografi che si occupano dei neologismi, del resto, si basano soprattutto sugli archivi dei giornali per scegliere le nuove voci da inserire.

Nell’immagine, tratta dal Corriere.it di ieri, sotto la categoria geoengineering (l’italiano geoingegneria compare dopo come sinonimo secondario) si parlava del climate change (cambiamento climatico è forse considerato provinciale), e sotto l’etichetta di gender gap (divario di genere è roba da boomer) dello smart working, in primo piano e in grande rispetto al “lavoro in remoto” scritto dopo e in piccolo. A essere pignoli quest’ultimo “anglicismo” non sarebbe un “prestito” visto che gli inglesi non lo usano (né lo capirebbero) perché dicono remote o home working, cioè lavoro da remoto, da casa o telelavoro come si dice anche in francese e in spagnolo… ma è pur sempre un prestito di due radici internazionali ricombinate all’italiana, e questo è il segno che la nostra lingua è molto vispa e creativa, come qualcuno ha osservato in modo acuto.
A proposito di “case”, nel senso di house al plurale, mi permetto solo di muovere una critica al titolo “Case green” perché di primo acchito mi è venuto da leggerlo come “chèis grin” (sul modello di case history, che nulla ha a che vedere con la storia delle edificazioni); solo procedendo nella lettura mi sono accorto che non riguardava il grave problema dei case di plastica non ecologica dei computer (un tempo detti anche custodie, casse, l’esterno, il guscio, le scatole, scocche o involucri) o delle cover degli smartphone e dei device (i telefonini e i dispositivi non avrebbero la stessa evocatività). No, si intendeva proprio il vecchio concetto di casa come abitazione (la location dove risiediamo), e forse sarebbe stato più moderno e più chiaro parlare di green building (ma nessuno è perfetto, nemmeno il Corriere). Comunque sia, l’inglese occupa la parte alta della gerarchia delle parole, per esprimere i concetti fondamentali, e l’italiano occupa il ruolo inferiore di sinonimo di rafforzo, che aiuta il popolino alla comprensione (e affermazione) dell’itanglese.
Urbex, urbexer (e prossimamente urbexing?)
Gli anglicismi servono per introdurre i concetti nuovi (non a caso la metà dei neologismi del Duemila è in inglese) come nell’articolo sugli urbexer, parola che è stata virgolettata in quanto non ancora registrata per esempio tra i neologismi della Treccani, che riporta solo la voce urbex tratta da un articolo di Repubblica D: “Sono persone normali, fanno lavori diversi – chirurghi, insegnanti di geografia, una signora con quattro figli programmatrice di computer, registi, autisti di bus, addetti ai call center – ma quando ‘staccano’, o nel weekend, si cambiano i vestiti come i supereroi e diventano ‘urbex‘: esploratori urbani”.
Quest’ultima citazione – composta da 46 parole – contiene solo 6 vocaboli inglesi, che rappresentano appena il 13% del lessico utilizzato; è bene ribadirlo per chi pensa che la presenza dell’inglese sia ormai ingombrante, sbagliandosi: l’87% delle parole rimane infatti in italiano, il che prova inequivocabilmente che l’itanglese è tutta un’illusione ottica. Ma, senza voler far polemiche, la citazione riportata dalla Treccani è poco precisa, e infatti il giornalista del Corriere si rivela ben più corretto dal punto di vista filologico e lessicale: distingue molto lucidamente il fenomeno dell’urbex, cioè dell’esplorazione urbana (contrazione di Urban Exploaration che si scrive preferibilmente con le iniziali maiuscole), da coloro che la praticano, che è molto più opportuno declinare in urbexer: così come ci sono i blogger e non i bloggatori, i runner e non i corridori come si diceva negli anni Sessanta, anche gli esploratori degli edifici abbandonati si declinano con le nuove flessioni in “er” che caratterizzano le norme dell’itanglese (per saperne di più potete consultare una Grammatichetta).
Del resto questa nuova pratica è stata inventata negli Usa, e a noi non resta che imitarla e ripeterla nella loro lingua, ci mancherebbe altro! Parlare di esploratori urbani sarebbe patetico, oltre a evocare i giovani esploratori che fa molto manuale delle giovani marmotte.
Chissà se presto non si comincerà a parlare anche di urbexing che segue la regola di baby sitter → baby sitting e delle nuove declinazioni dell’inglesorum: blog, blogger, blogging; surf, surfer, surfing; shop, shopper, shopping; work, worker, working… per il momento questa variazione non si è ancora sviluppata. Ogni cosa a suo tempo, nel frattempo è stato introdotto il neologismo copilot.
“Un solo nome: copilot!” Altro che assistenti virtuali e copiloti
Copilot non è ancora stato registrato tra i neologismi Treccani né tra quelli della Crusca (e nemmeno sul dizionario AAA delle Alternative Agli Anglicismi, aggiungo con immodestia) ma sul fatto che presto si diffonderà – grazie alla fortuna dell’intelligenza artificiale – forse ci si potrebbe scommettere.
Fino a ieri era il nome commerciale di un prodotto rilasciato l’anno scorso, Microsoft 365 Copilot, ma nell’articolo la parola compie il salto che ne fa una parola “comune”, e per chi non sa cos’è basta cercare in rete per comprendere tutto in modo chiaro.
– È un “nuovo tool di AI [è sempre meglio invertire l’ordine dell’acronimo all’inglese] di aiuto per la nostra produttività”.
– “Un tool?” direbbe un povero ottentotto che parla solo l’italiano. Un “competecnico” che si esprime invece in itanglese, per essere più trasparente e arrivare anche agli idioti, potrebbe rispondere:
– “Una suite, se preferisci, che combina l’intelligenza artificiale con le funzioni di una moderna chatbot. Basta scaricarla sul tuo device” [nota: suite un tempo era francese, anche se oggi il significato informatico ci arriva dall’inglese].
– Ma non si potrebbe dire assistente virtuale o copilota?
– Copilota, basta leggere sul dizionario, si riferisce a un assistente di volo, o alla peggio a chi fa da secondo nei rally. Assistente digitale è troppo generico, non è proprio come il tecnicismo inglese… Ma qual è il problema delle parole straniere? Non sai che le lingue evolvono? Sei rimasto al purismo e alla guerra ai barbarismi del ventennio?

– A dire il vero non vedo parole straniere, vedo solo parole inglesi e pseudoinglesi. Quanto al purismo… se dici che il significato di copilota è solo quello storico forse il purista sei proprio tu: stai cristallizzando l’italiano nella lingua dei morti, invece di creare neologismi. Credi che l’italiano si debba evolvere solo attraverso la sua anglicizzazione? Nemmeno copilot è presente sui dizionari, fino a prova contraria, e in inglese vuol dire appunto copilota.
– Ma cosa c’entra? Anche mouse vuol dire solo topo, se è per quello, ma da noi è un prestito di necessità, o vuoi fare come i francesi, gli spagnoli, i portoghesi, i tedeschi e tutti gli altri che lo hanno tradotto?
Comunque la pensiate, segnalo che giovedì 21 marzo interverrò a Pordenone (Biblioteca civica, ore 17,45) in un dialogo organizzato dalla Società Dante Alighieri a cui parteciperà il professor Domenico De Martino dell’università di Pavia, linguista, dantista e collaboratore della Crusca. Il titolo è: “Dove va la lingua italiana?”. E, come si evince dalla grafica, la conversazione moderata da Carlo Vurachi ruoterà proprio sul tema dell’inglese.
Per chi è interessato all’argomento segnalo anche una diretta di qualche giorno fa, disponibile su YouTube, in cui sono stato intervistato da Matteo Brandi e Ludovico Vicino del partito Pro Italia.