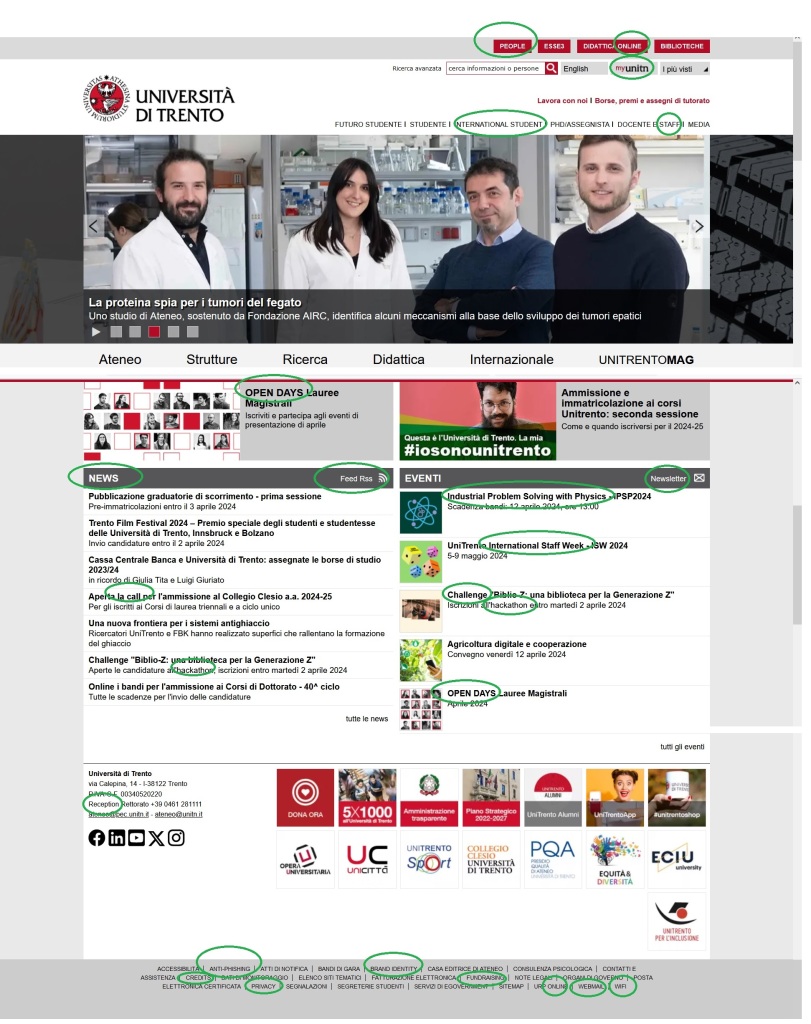Tra pochi giorni sarà formalizzata la decisione dell’università di Bologna che ha deciso di sopprimere il corso di Economia del Turismo in italiano che si svolge a Rimini. Dal prossimo anno diventerà “Economics of Tourism and Cities” e si terrà solo in lingua inglese.
Qual è la novità? Il corso in inglese era già stato introdotto e già esisteva: la novità è che viene abolito quello in italiano per insegnare solo in inglese.
Questa decisione ha suscitato le proteste sia dei cittadini, che vogliono studiare nella propria lingua madre visto che è un loro diritto e che pagano le tasse, sia dalle associazioni degli albergatori che spiegano come quell’indirizzo di studi avesse da sempre un fortissimo legame con il territorio. In pratica gli studenti che uscivano da quel corso trovavano subito lavoro nelle realtà alberghiere locali. E l’offerta formativa di quella facoltà richiamava a Rimini moltissimi studenti giovani provenienti da ogni regione d’Italia. La sua cancellazione per passare all’inglese punta soprattutto agli studenti stranieri, che però una volta formati non lavoreranno a Rimini ma torneranno nei propri Paesi, anche perché se non parlano in italiano cosa li può trattenere?
Visto che nessuno o quasi dà voce al malcontento, l’associazione/portale Italofonia ha mobilitato tutti gli Attivisti dell’italiano predisponendo un modulo per inviare una protesta digitale indirizzata all’Università e in copia al Ministero dell’Università e Ricerca, all’accademia della Crusca, e ai giornali locali.
In pochi giorni sono partite centinaia e centinaia di proteste, tanto che il Resto del Carlino ha titolato: “Pioggia di mail all’Università: Salvate il corso in italiano”.
Intanto, la pioggia si fa sempre più fitta, e l’ateneo – spiazzato – ha dovuto rispondere attraverso una dichiarazione che lo stesso giornale ha riassunto in nuovo pezzo: “Corso di laurea in inglese: Una scelta condivisa“.
La risposta non ascolta né tiene conto dei pareri contrari e dei cittadini, annuncia di continuare nella strada intrapresa, e rivolta la frittata sostenendo che si tratterebbe di una “scelta condivisa” (da chi? dai vertici della scuola-azienda che non racconta di come l’associazione Promozione Alberghiera si sia invece espressa in senso contrario, secondo le testimonianze raccolte) appellandosi alle solite tiritere:
“Le scelte che riguardano i progetti didattici sono il risultato di un percorso ben definito, lungo e con diversi passaggi. Un corso di laurea ha una gestazione pluriennale. Si tratta di scelte meditate, non certo di decisioni prese dall’oggi al domani. L’inglese è una lingua che apre al mondo. Per il territorio è un’opportunità (…) Dopo un’attenta e ponderata valutazione, abbiamo optato per l’inglese come lingua ufficiale del corso, scelta in linea con l’elevato livello di internazionalizzazione che caratterizza tradizionalmente il campus di Rimini.”
Queste scelte “meditate” seguono gli interessi dell’ateneo, che non coincidono con quello dei cittadini e degli italiani. Attraverso la manipolazione delle parole, la cancellazione dell’italiano e le difficoltà degli studenti si trasformano in un’imprecisata “opportunità per il territorio”. Il concetto di “internalizzazione” cela invece l’insegnamento in inglese e solo in inglese – non nelle lingue straniere e all’insegna del plurilinguismo – e forse si potrebbe meglio parlare di colonizzazione linguistica e di dittatura dell’inglese, visto che questa strana “internalizzazione” a senso unico implica l’anglificazione della formazione dei Paesi non anglofoni. Come se tutti i turisti tedeschi, spagnoli, francesi e gli altri che giungono in Italia si esprimessero normalmente in inglese (altra bufala che non risponde alla realtà).
Dietro questa visione c’è in gioco il diritto di studio nella nostra lingua madre, una partita vitale per l’italiano.
Italofonia ha intervistato un’albergatrice nonché mamma di uno studente che ha spiegato disperata:
“Mio figlio e gli altri ragazzini della sua classe non possono più scegliere. Vede, noi siamo a Rimini, qui c’è il cuore del turismo, noi viviamo di turismo, e questa facoltà era molto ambita dai ragazzi di zona. Ed era già in due lingue, ma separate: un percorso di Economia del Turismo, in italiano, pensato per le esigenze del territorio, e Turismo Internazionale, in inglese. Ora questa scelta è stata tolta. E questo li metterà in difficoltà.“
Passando dal punto di vista dei cittadini a quello di un esperto come Michele Gazzola [1], economista dell’Università dell’Ulster che ci ha risposto appoggiando il nostro appello, le motivazioni di queste scelte che portano all’anglificazione della formazione universitaria nascono da un preciso interesse economico.
La parola chiave per comprendere ciò che è in atto da tempo e che nei prossimi vent’anni potrebbe esplodere in modo ancora più profondo è “razionalizzazione”, ci ha scritto Gazzola, che ha così sintetizzato la questione:
“Le università hanno prima aperto corsi paralleli in italiano e in inglese, e adesso stanno chiudendo quelli in italiano perché costa troppo averne due uguali, e perché tanto sanno che con un corso in inglese possono coprire sia il mercato nazionale (sempre più piccolo a causa della denatalità) sia quello internazionale. Tanto lo studente italofono non ha scampo, può studiare in italiano solo in Italia (e in pochissimi altri posti all’estero), quindi se lo si priva del corso in italiano non andrà via.”
L’ateneo di Bologna, insomma, pensa solo ai propri interessi e a reclutare gli studenti stranieri per fare numero e batter cassa – è il bel modello delle nuove scuole-aziende che hanno come “mission” il profitto — ed è poco interessato al diritto allo studio in italiano. Dietro le motivazioni ufficiali c’è proprio il fatto che il numero degli iscritti non è poi così interessante per l’Università che si vuole allargare a scapito della qualità della didattica e delle esigenze reali degli studenti del nostro Paese.
Il progetto di cancellazione dell’italiano dalla scuola alta
Tutto è iniziato al Politecnico di Torino che nell’anno accademico 2007-2008 ha avviato i primi corsi in inglese rendendoli gratuiti, al contrario di quelli in italiano, per fare in modo che partissero con un buon numero di iscritti. Ma così facendo discriminava il pubblico pagante che voleva studiare in italiano.
Il secondo episodio, ancora più grave perché ha costituito il precedente che ha fatto saltare il sistema, è avvenuto nel 2012, quando il Politecnico di Milano ha deciso di estromettere l’italiano dalla formazione di ingegneri e architetti che avrebbero potuto studiare solo in inglese. Maria Agostina Cabiddu [2], docente di Istituzioni di diritto pubblico, ha raccolto le proteste di un agguerrito gruppo di insegnanti che, dopo un appello al presidente della Repubblica Mattarella, si sono rivolti al Tar della Lombardia che ha dato loro ragione.
Ma l’ateneo e il Miur – cioè il Ministero dell’istruzione italiano che pare lavorare in favore dell’inglese – non hanno accettato il verdetto e si sono opposti. Dopo lunghi e complicati corsi e ricorsi in cui è intervenuta anche la Corte Costituzionale, è finita con una sentenza (a mio avviso “cerchiobottista”) che da una parte sanciva la “primazia” della lingua italiana nell’università, ma ammetteva i corsi in inglese con una logica di buon senso e proporzionalità che però non era definita, ma lasciata alla discrezione delle parti. E nell’atto finale della vicenda è andata a finire che il Politecnico se ne è infischiato della “primazia” sancita solo sulla carta, e ha continuato a erogare corsi quasi esclusivamente in inglese con una concezione della proporzionalità diciamo così “discutibile”. In sostanza lo spirito della legge viene aggirato con il semplice inserimento di qualche sporadico corso in italiano, magari delle materie più marginali.
Tutto ciò non era affatto destinato a rappresentare un caso isolato, fa parte di un preciso progetto – imposto dall’alto in modo surrettizio e senza interpellare gli italiani – che negli anni successivi si è diffuso in modo sempre più preoccupante. Gli altri atenei-aziende aspettavano solo la via spianata per seguire la stessa strategia per loro più remunerativa. E infatti, Maria Agostina Cabiddu, un’altra importantissima voce che ha raccolto il nostro appello, ha commentato:
“Ci eravamo mossi a suo tempo proprio perché avevamo capito che si trattava di un progetto pilota.“
Quello che è avvenuto negli anni successivi e quello che sta avvenendo in questi giorni è l’allargamento di questo modello, che dopo tanti altri casi è da poco stato perseguito anche dalla Bocconi di Milano, ma soprattutto rischia di estendersi anche alle scuole secondarie, come ho già denunciato a proposito del liceo Avogadro di Torino.
La novità delle proteste di Rimini è che a mettere in discussione questo progetto “italianicida” e “linguicista” [3] non ci sono solo associazioni come Italofonia e comunità virtuali come quella degli Attivisti dell’italiano, ma anche gli stessi imprenditori, le associazioni degli albergatori, e i cittadini che lottano – mi sembra impossibile doverlo raccontare – per il diritto alla studio nella propria lingua madre!
Tutto ciò è inaccettabile. Ed è inaccettabile che la cancellazione dell’italiano dalle scuole avvenga nel silenzio mediatico – a parte un giornale locale come il Resto del Carlino – e nel vuoto di prese di posizioni di intellettuali e politici.
La speranza è che le nostre proteste possano almeno riaprire un dibattito. La decisione dell’Università di Bologna sembra ormai presa, anche se formalmente sarà ufficializzata entro il 29 febbraio. Ma è importante far arrivare più voci possibili di dissenso per cercare di fare in modo che altri atenei, prima di scegliere di andare in questa direzione, debbano tenere conto anche delle resistenze dei cittadini oltre ai numerini del proprio “businness plan”.
Chi vuole aiutare i riminesi, gli albergatori, Italofonia e soprattutto il diritto allo studio in italiano e la lingua italiana si faccia sentire, e si unisca al nostro appello.
In meno di 30 secondi puoi aderire alla protesta sottoscrivendo e inviando un messaggio precompilato, ma è possibile personalizzarlo a piacere, attraverso il modulo a fine di questo articolo.
Grazie.
Antonio Zoppetti
——–
Note
[1] Per approfondire la questione: Michele Gazzola, “La ‘anglificazione’ dell’università in Europa è evitabile?Analisi e proposte per una università plurilingue” (2023).
[2] Maria Agostina Cabiddu ha curato: L’italiano alla prova dell’internalizzazione (goWare ed Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 2017).
[3] Il linguicismo è concetto introdotto dalla finlandese Tove Skutnabb-Kangas: come il razzismo e l’etnicismo discriminano sulla base delle differenze biologiche oppure etnico-culturali, il linguicismo è la discriminazione in base alla lingua madre, che porta a giudizi sulla competenza o non competenza nelle lingue ufficiali o internazionali.